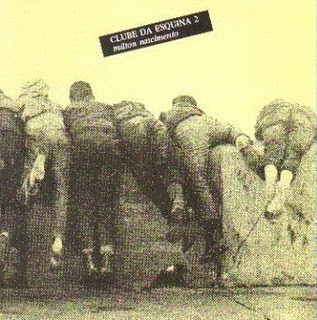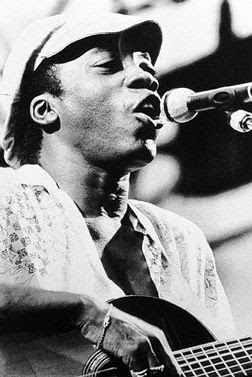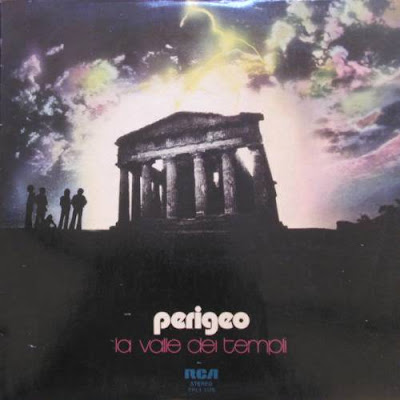Dalton: Argitari (1975)
 Dopo aver ottenuto un moderato riscontro col loro primo album “Riflessioni, idea d’infinito” e la vittoria a un Festival Pop a Zurigo (dove comunque va detto che il Prog Italiano non ebbe molti cultori), il quintetto dei Dalton pubblica nel 1974 il singolo “La donna e il bambino / Il vuoto” che anticipa il loro secondo lavoro a 33 giri.
Dopo aver ottenuto un moderato riscontro col loro primo album “Riflessioni, idea d’infinito” e la vittoria a un Festival Pop a Zurigo (dove comunque va detto che il Prog Italiano non ebbe molti cultori), il quintetto dei Dalton pubblica nel 1974 il singolo “La donna e il bambino / Il vuoto” che anticipa il loro secondo lavoro a 33 giri.
Pur riferendosi ancora a mostri sacri del rock però, balza subito all’orecchio che la band viaggia su binari assai distanti dal groove progressivo degli esordi.
Il lato A non va oltre un volonteroso annacquamento di un qualsiasi brano dei Jethro Tull e quello B suona come una malinconica ballata melodica in stile New Trolls, ma con qualche break ritmico in più.
Nel frattempo, è anche curiosa la decisione del gruppo di prestare la propria immagine a una marca di jeans, realizzando un 45 pubblicitario a nome “Jeans Master Orchestra”, dato in omaggio con i pantaloni e contenente due brani firmati Cereda-Selieri-Reduzzi: “What’s the use of a sail” e “A che serve una vela”: lo stesso pezzo insomma, ma in due versioni diverse.
E’ quindi evidente che nei Dalton qualcosa sta per cambiare, e la conferma arriva poco dopo con l’abbandono del leader Temistocle Reduzzi, sostituito dal cantante Massimo Moretti (che però verrà citato sempre e solo come corista) e del flautista Alex Chiesa al cui posto subentra il tastierista Giancarlo Brambilla.
Cambia anche la discografica e nel 1975 la nuova line-up pubblica per la IAF il 33 giri “Argitari”, dotato di una sontuosa copertina a tinte forti apribile in tre parti e contenente ben 10 brani della durata media di tre minuti e mezzo.
In sostanza, un album di canzoni che poco o nulla ha a che vedere col progressive e che farà rimpiangere a non pochi critici il precedente “Riflessioni...”.
Viziato da non pochi problemi tecnici per cui sembra addirittura che sia stato pesantemente restaurato nella ristampa in CD con tanto di parti di flauto aggiunte ex-post, il nuovo album si dimostra sin dai primi due brani “L’impossibile è possibile” e “Ho visto il sole” una raccolta di canzoni in stile cantautorale con forti implicazioni popular - freak.
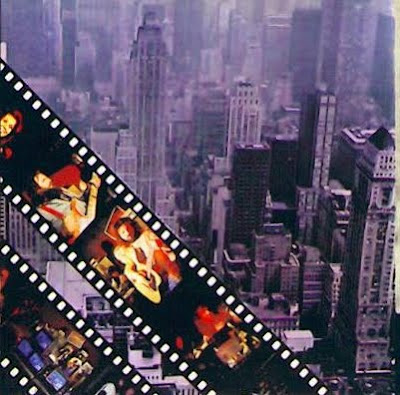 Personalmente, non ho mai sentito l’originale ma, se dovessi avallare il fatto che sulla ristampa il flauto è stato veramente aggiunto a posteriori, capirei i miei colleghi di Progarchives che giudicarono l’album del '75 “a bit of a disaster and criticized accordingly”.
Personalmente, non ho mai sentito l’originale ma, se dovessi avallare il fatto che sulla ristampa il flauto è stato veramente aggiunto a posteriori, capirei i miei colleghi di Progarchives che giudicarono l’album del '75 “a bit of a disaster and criticized accordingly”.
Ascoltando poi la terza track “Ho ritrovato la mia donna” si comprendono anche anatemi quali “Dalton is a second-rate blues-rock band” o “this is a mediocre and forgettable record”.
Poi, naturalmente, c’è anche il sentimentale di turno che gli attribuisce un bel 10 out of 10 reputando il disco "melodrammatico, intenso e imprescindibilmente rappresentativo del Prog e del Folk acustico italiano" ma, onestamente, limiterei questo giudizio alla sola testa di chi l’ha pensato.
“Argitari” è semplicemente la testimonianza di come un gruppo provinciale stesse rapidamente rientrando nei ranghi della forma-canzone dopo un piccolo e isolato exploit trasgressivo.
Se questa definizione vi sembra troppo rigida, ascoltate la title track e capirete immediatamente quello che volevo dirvi: suoni modestissimi, barocchismi di terza mano, nessuna dinamica ritmica, citazioni melodiche a non finire, durata da airplay e ricalco delle più ovvie melodie da classifica.
Se ciò non bastasse, si ascolti anche la versione italiana di “Blowin in the wind” di Dylan (“La risposta”) in chiave hippy e spero che a questo punto sarete convinti dell’assoluta prescindibilità di questo prodotto. 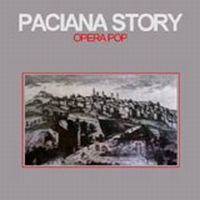 Non avendo null’altro da dire sui Dalton che si sciolsero nel 1979 (Locatelli formerà i Mo.Do e Reduzzi entrerà in un’orchestra da ballo dopo aver suonato con Cereda nell’opera pop “Paciana Story”), chiuderei qui la scheda con un’ultima osservazione.
Non avendo null’altro da dire sui Dalton che si sciolsero nel 1979 (Locatelli formerà i Mo.Do e Reduzzi entrerà in un’orchestra da ballo dopo aver suonato con Cereda nell’opera pop “Paciana Story”), chiuderei qui la scheda con un’ultima osservazione.
Al di là del giudizio estetico, un lavoro come “Argitari” fu anche la dimostrazione di come gradualmente la cultura musicale antagonista si stesse modificando non solo ai livelli più alti, ma anche negli strati inferiori.
Ossia, non c’erano solo i Napoli Centrale, i Nova, i Maxophone o Le Orme a contaminare e diversificare il Prog primigenio del ’70-’73, ma lo facevano persino anche quei gruppi che, proprio in quanto marginali, avrebbero potuto osare ancora qualcosa.
Con la sola eccezione degli E. A. Poe e di pochissimi altri, l’Italia si stava riempiendo sin dalle fondamenta di cloni dei Pooh (es: La bottega dell’arte) e/o di bands totalmente disinteressate al rock progressivo. Di fatto, in capo a un anno esso sarebbe sopravvissuto solo come uno dei tanti “ingredienti” del nuovo rock italiano.
In questo senso, già nel ’75, i Dalton avevano compiuto la loro controrivoluzione.